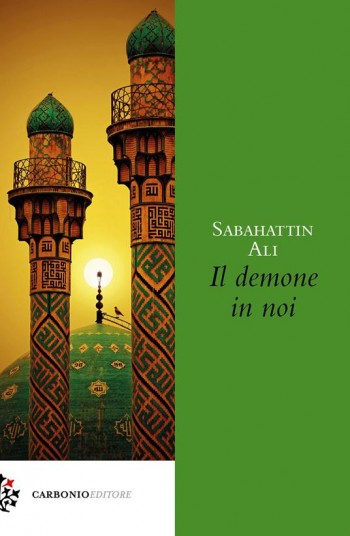
Sabahattin Ali Il demone in noi
Carbonio Editore, collana Origine, 2024, traduttore Nicola Verderame, 300 pagine, 18,50 euro Narrativa Straniera | Romanzo | Storia
21/01/2025 di Laura Bianchi
"In noi non c’è un demone. In noi c’è incapacità. Pigrizia. Indecisione. Ignoranza. E una cosa ancora più tremenda: la tendenza a evitare di guardare in faccia la realtà."
Siamo a Istanbul, negli anni Trenta del Novecento, durante la Repubblica di Atatürk; Omer e Macide intrecciano una storia d'amore che solo apparentemente trova spazio in quel tempo, ma che contiene in sé ogni tratto della storia emblematica, che attraversa le decadi per giungere con forza fino a noi, diventando nostra contemporanea. E il merito è della penna sottile, incisiva e lucidissima di Sabahattin Ali, uno degli interpreti più importanti della letteratura e della società turche, che, pur perseguitato e arrestato per propaganda comunista e per le proprie critiche al regime, riuscì a pubblicare e a imporsi come una voce autorevole e innovativa.
In questo splendido romanzo, Il demone in noi, tradotto magistralmente per Carbonio da Nicola Verderame, lo scrittore esprime al massimo grado la propria arte, delineando alcune figure indimenticabili, e cogliendole nelle loro rispettive lotte per affermarsi nella vita e nella società, attraverso la lotta contro le ipocrisie e i pregiudizi di una mentalità ancora imbevuta di stereotipi e bloccata da vincoli vecchi di secoli.
Omer, nel suo incontro con l'inquieta e indipendente Macide, è combattuto da una pressione interna, che egli individua in un "demone", ma che l'autore è abile nel far sì che il lettore identifichi con la tradizione, con il patriarcato e quanto essi richiedono a un uomo di quei tempi (e, in molti casi, anche dei nostri). Così la figura femminile potrebbe assumere il ruolo di una Beatrice terrena, che possa guidare il protagonista alla conquista di una sua dimensione nella società maschilista, che egli rifiuta solo a parole, ma di cui accetta quelli che gli sembrano dogmi.
Pur non rivelando la conclusione di una vicenda, che si fa più intricata, nel rispetto del genere del romanzo di formazione, è comunque necessario sostenere che la figura di Macide risulta, in ultima analisi, quella in cui Ali ripone la maggiore energia comunicativa, in quanto confida che i lettori, soprattutto le lettrici della sua epoca (e forse anche della nostra), possano trarre ispirazione per un comportamento nobile e coerente.
A questo si aggiunge l'indiscussa abilità dell'autore nel tracciare la psicologia dei suoi personaggi con pochi, essenziali tratti, attraverso sguardi, gesti e atteggiamenti, più ancora che attraverso i dialoghi. Si legga, ad esempio, questo passo, che descrive un momento in cui Macide scrive una lunga e dolorosa lettera a Omer: "Macide posò lentamente la penna sul tavolo. Digrignò i denti. Non riuscì più a controllarsi, si accasciò sui fogli e scoppiò in lacrime. Restò a lungo in quella posizione, forse quindici o venti minuti. Non era troppo agitata. Stava versando lacrime silenziose e miti, come quando tre mesi prima aveva pianto per la morte del padre. Rialzò la testa. Si asciugò il viso col dorso della mano sinistra, prese la penna e scarabocchiò sulle ultime righe. Poi, con una scrittura incerta e molto frettolosa, continuò."
Ali sa come parlare d'amore, di separazione, di conflitto, di politica e di musica, ma soprattutto sa parlare di noi, dei nostri blocchi, che chiamiamo demoni, ma a cui, ci suggerisce, dovremmo dare un nome più appropriato: paure, di cui dovremmo liberarci al più presto, per vivere in modo completo.
Sabahattin Ali Autore di cinque raccolte di racconti, un dramma e tre romanzi, tra cui l’iconico Madonna col cappotto di pelliccia (1943) un vero e proprio libro di culto in Turchia, poesie e articoli a sfondo politico, è stato uno dei massimi esponenti della letteratura turca del Novecento. Comunista convinto, nei primi anni della Repubblica di Turchia fu incarcerato più volte. Morì a 41 anni, ucciso al confine con la Bulgaria mentre cercava di attraversarlo per fuggire in Europa. Quando si sparse la notizia, un quotidiano nazionale pubblicò una foto degli effetti personali di Ali: la sua ventiquattrore, i suoi occhiali e il binocolo, una fotografia di sua moglie e una copia di Eugenio Onegin. Questi oggetti non furono mai restituiti alla famiglia.